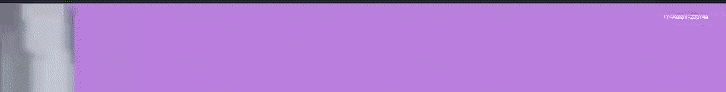La Legge della parola (terza parte)
Giobbe, come una quercia fulminata, lancia verso il cielo il suo grido. La prova lo fa veemente nella sua ricerca di Dio, lo rende una figura che attraversa i secoli con il suo grido, lo fa emblema tanto della pazienza quanto della forte attesa.(Gianfranco Ravasi)
Massimo Recalcati, proseguendo la lettura del testo biblico, nel sesto capitolo del libro, La lotta di Giobbe, dimostra che La Legge della parola non è scritta sulle tavole di pietra ma intende inscriversi soprattutto nel cuore degli uomini.
Infatti anche il libro fondamentale di Giobbe rivela che i grandi temi del senso della sofferenza umana e della vita, della violenza del male, dell’enigma del dolore dell’innocente, dello scandalo dell’ingiustizia subíta del male, saranno ereditati dalla psicanalisi (l’arte della decifrazione dei sintomi della sofferenza umana), con costante riferimento all’opera di Freud e di Lacan, per i quali rispettivamente la religione è «una forma irrazionale di superstizione» e «una passione per il senso della vita».
Giobbe, uomo retto, giusto e timorato da Dio, si pone angoscianti domande di senso: Perché la violenza del male “senza motivo” e della sofferenza ingiusta subíta si accanisce su di lui innocente? Perché di fronte alla mannaia delle sventure (perdita dei suoi beni materiali e della tranquillità, malattia fatta di piaghe e ulcere sul suo corpo lacerato, abbandono dei familiari e degli amici) Dio è assente? Perché il suo grido di disperazione resta inascoltato?
Di fronte a questo drammatico quadro di dolore, di disperazione e di sventure Giobbe, uomo sofferente, innocente e incolpevole, e non solo paziente, lotta e non perde la fede nel Signore, resta onesto e fedele al suo Dio inflessibile che lo assedia, lo tormenta e lo percuote incessantemente, senza alcuna pietas e compassione.
Nel drammatico racconto biblico, accostato ad altri testi della letteratura (Nemesi di Philip Roth, La peste di Camus, le tragedie greche riprese da Schopenhauer e da Nietzsche) il povero Giobbe perseguitato, abbandonato e messo a dura prova dal mistero della sofferenza incomprensibile, in maniera ricorrente si interroga quale sia il vero volto di Dio. Se sia un tiranno crudele e senza pietà, un acerrimo nemico persecutorio o un padre amorevole, buono, “ponderato” che ha cura e soccorre gli uomini. Di fronte all’accanirsi del male, per non arrendersi, Giobbe chiede di parlare e discutere con Dio-Padre del male che lo colpisce.
La figura di Giobbe, «il giusto che soffre», è una tra le più scandalose della Bibbia perché non indietreggia di fronte al silenzio ostinato e all’assenza totale di Dio. Recalcati, nello scontro teologico tra Giobbe e i suoi amici, critica la teologia ingenua della retribuzione, sostenuta dagli amici teologi consolatori, che prevede la maledizione dell’uomo malvagio per le sue cattive azioni e che viene confutata senza riserve perché contrasta la versione di un Dio compassionevole.
Giobbe inerme, davanti allo scandalo della sua esperienza esistenziale, davanti all’assurdità inesplicabile del male, grida perché esige che l’Altro risponda, e angosciato non vuole rimanere abbandonato nell’estrema solitudine e nel vuoto. Giobbe vuole interrogare Dio perché risponda alle sue domande e resti accanto a chi è colpito dal male. Sebbene prostrato e afflitto vuole incontrare, vedere, parlare, interrogare direttamente l’Altro, Dio, senza arroganza.
Il racconto biblico di Giobbe, che sperimenta la gravità del dolore, il suo peso e la sua consistenza, si conclude con un «faccia a faccia» con colui che ama, con l’apparizione e l’incontro di Dio in persona che risponde alle domande del sofferente. Alla fine Dio premia la fede ostinata di Giobbe e la sua volontà di lotta per avere giustizia e sapere la verità, riconsegnandogli la libertà e facendogli capire la finitezza e la vulnerabilità umana e che il mondo è una creatura dell’amore di Dio e l’esistenza è un dono.
Dio, ribadendo la sua smisurata potenza miracolosa e generativa di Creatore dell’universo e l’incommensurabilità tra uomo e Dio, risarcisce Giobbe per la sua fede illimitata, capace di resistere alla prova e di comprendere che la sofferenza umana riflette la condizione ontologica dell’esistenza dell’uomo e del mondo.
Anche il perturbante libro sapienziale di Qohelet (conosciuto come l’Ecclesiaste), come il libro di Giobbe, si pone l’ineludibile domanda del senso della vita, e questo interrogativo viene affrontato nel settimo capitolo, Il fantasma idolatrico dell’essere e il resto di godimento, dove la parola ebraica hevel (vanità, soffio, vento, polvere, vapore, fumo, vuoto, niente) sta ad indicare l’inconsistenza, il carattere fondamentale dell’essere destinato a dissolversi, a ritornare inesorabilmente al nulla da dove proviene. «Tutto è nulla».
Il grande tema ontologico affrontato nell’enigmatico libro di Qohelet riguarda, infatti, la vacuità dell’esistenza, la caducità di tutte le cose, perché tutto è polvere e il destino di ogni essere umano è quello di ritornare a essere polvere. («Dalla polvere tutto è venuto e alla polvere tutto ritorna»). Questa vanità della vita si ripete perché non c’è mai «niente di nuovo sotto il sole». La vita, priva di senso, si rivela come una caduta traumatica nell’insensatezza dell’esistenza terrena.
Questo concetto di ripetizione, secondo Lacan, è uno dei quattro fondamentali concetti delle psicanalisi, secondo il quale ogni iniziativa umana, che pretende di generare il nuovo, viene riassorbita nella legge inesorabile della ripetizione, che consuma la vita. L’essere umano, splendore e polvere insieme, ritorna senza scampo al nulla dal quale proviene. La sua esistenza è un soffio, qualcosa di fuggitivo destinato a perire dove la morte è sempre presente e costituisce il telos più profondo della vita, corrosa dal divenire del tempo.
La più grande follia dell’uomo è quella «di volersi fare essere, di consistere, di esistere come una sostanza che è causa di se stessa», di rigettare la sua fragilità e finitudine, di «sostituire alla mancanza (che attraversa la nostra esistenza) a essere una consistenza d’essere». L’uomo è continuamente tentato dal suo fantasma idolatrico dell’Io, a costituirsi come un Dio, a volersi comparare a Dio, a deificare utopicamente il suo essere per affermare il suo godimento narcisistico del mondo. Si sente centro e padrone del mondo, soggetto autonomo.
Questo è un tema ampiamente ripreso dalla psicanalisi, in particolare da Lacan che mette in risalto il carattere idolatrico della passione narcisistica dell’uomo che «tende a elevare l’Io al rango di una statua ideale», che porta l’uomo all’idealizzazione dell’Ego, all’eccessivo attaccamento all’Io e ai suoi illusori e perversi desideri.
Il predicatore Qohelet, per ridurre l’infelicità umana, indica la castrazione del suo Ego e delle sue passioni idolatriche, perché l’idolatria di se stesso è un inganno, un miraggio, un desiderio in quanto «tutto è un soffio», è vanità. La seduzione idolatrica dell’essere è la vera perversione che abita l’umano.
L’unico bene dell’uomo è il godere «senza mancanza» nella vita, in maniera minimalista, di ciò che ha senza ricorrere affannosamente quello che gli manca. La vita, destinata inesorabilmente a finire, deve mirare alla gioia di godere “adesso”, nell’essere oggi”, riconoscendo così il carattere storico della esistenza umana. E senza la presenza e la fede nell’Altro la vita dell’uomo è vuota. (continua)
News-24.it è una testata giornalistica indipendente che non riceve alcun finanziamento pubblico. Se ti piace il nostro lavoro e vuoi aiutarci nella nostra missione puoi offrici un caffè facendo una donazione, te ne saremo estremamente grati.